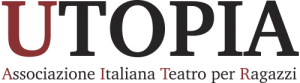IL PLAYBACK THEATRE
Ascolto, empatia e il piacere dell’incontro
INTERVISTA A ELISA RAVETTA
Decido di intervistare Elisa Ravetta, co-fondatrice della Compagnia Teatro di Mutuo Soccorso di Pavia, compagnia di Playback theatre, dopo aver visto la forza di questo linguaggio artistico utilizzato in ambito sociale, in un progetto che ha visto coinvolte le donne accolte nella Casa Rifugio del nostro comune e l’intera cittadinanza, dimostrando quanto l’arte possa creare connessioni, offrire nuovi punti di vista e dare voce a esperienze spesso taciute. Il Playback Theatre è questo, una forma di teatro partecipativo basato sull’ascolto, sulla relazione e sulla restituzione del vissuto collettivo, un linguaggio artistico capace di toccare le corde più profonde delle emozioni e promuovere il cambiamento sociale.
Ecco cosa mi ha raccontato, del linguaggio e della sua esperienza.
- Che cos’è il Playback theatre, da dove nasce e qual è la sua specificità?
L’essenza del Playback Theatre è quella di mettere in scena, improvvisando, le storie delle persone, rispondendo al bisogno umano di narrare e di ascoltare racconti. Attraverso la rappresentazione scenica emergono i significati simbolici profondi dell’esperienza umana, creando uno speciale legame e senso di appartenenza in chi partecipa. Il pubblico è infatti parte attiva del processo spontaneo e creativo che si origina e sviluppa nello spazio-tempo della performance.
A partire dall’osservazione del gioco di ruolo dei bambini nei giardini della Vienna di inizio secolo, Jacob Levi Moreno, padre dello psicodramma, intuì le potenzialità
pedagogiche, terapeutiche e di trasformazione sociale del teatro e del gruppo. Negli anni settanta Jonathan Fox coniuga il teatro sperimentale con le tecniche di
conduzione di J. L. Moreno e sviluppa il Playback Theatre. La prima compagnia di Playback Theatre è stata fondata nel 1975, da un’intuizione di Jonathan Fox, a
New York. Il Playback Theatre nasce così come una delle forme sperimentali delle esplorazioni teatrali degli anni Settanta, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e di portare il Teatro nella realtà quotidiana, rompendo con la tradizione del testo scritto. Da allora si è divulgato in tutto il mondo con compagnie e performer in oltre 30 paesi. Si realizza in svariati setting, sia per la sua funzione di connettere le persone in ambito di comunità allargate (teatri, convegni, meeting) sia per il suo utilizzo in ambito educativo, psicologico e formativo (in azienda, in campo psico- sociale, sanitario e in contesti di emergenza).

- Come ci si avvicina al Playback theatre, ci sono scuole o corsi specifici?
In Italia ci sono diversi corsi di avvicinamento al Playback coordinati dalle compagnie in varie città d’Italia. Vi è la Scuola Italiana di Playback Theatre a Torino e a Bologna accreditata al Center for Playback Theatre di New York, cuore di tutte le formazioni, creato da Jonathan Fox, co-fondatore del Playback Theatre con Jo Salas. Il Center sostiene lo sviluppo etico e artistico del Playback Theatre, promuovendo in tal modo comunità più sane, più civicamente impegnate e inclusive. Sostiene l’eccellenza e la pratica etica del Playback Theatre nel mondo e offre una completa formazione internazionale; funge da risorsa educativa e supporta la più ampia comunità di Playback attraverso la sua rete di formatori accreditati e scuole affiliate.
- Tu, perché ti sei avvicinata a questo linguaggio?
Mi sono avvicinata casualmente nel 2007, durante il primo anno della Scuola di Teatro Sociale che frequentavo a Pavia.
Ho avuto l’occasione di seguire una formazione con Lina Fortunato e da lì ho intrapreso questo percorso insieme alla crescita come operatrice di Teatro Sociale e di Comunità. Ho seguito poi diverse specifiche formazioni con Nadia Lotti, Gigi Dotti e nel 2010 con lo stesso Jonathan Fox. Ho trovato nel PbT l’unico spazio, per me, in cui potessi generare un atto di servizio per il pubblico stando in scena (e solo anni dopo conducendo le performance): l’attrice del PbT ha un compito molto diverso dall’attore o dall’improvvisatore più classico, l’ascolto che si mette in atto va oltre le abilità artistiche, ci si allena ad entrare in empatia e a servizio del narratore e del pubblico presente, col corpo e attraverso un’azione simbolica con non vuole riprodurre con precisione il racconto, ma lo vuole restituire trasformato attraverso la messa in scena.
- Spesso il Playback theatre viene utilizzato in gruppi, in ambito formativo e anche nelle scuole, per affrontare tramite il linguaggio teatrale tematiche importanti come la parità di genere. Come vivono i ragazzi e le ragazze questo linguaggio?
Il Playback Theatre è una metodologia molto versatile ed efficace in differenti contesti, poiché si presta a numerose applicazioni in ambito artistico, educativo, formativo e psicosociale. Gli incontri con la Compagnia Teatro di Mutuo Soccorso di Pavia, gruppo di Playback Theatre che ho co-fondato insieme a Lina Fortunato e ad altri fantastici attori/operatori, creano l’occasione di sperimentare un linguaggio in cui gli ingredienti necessari sono il rispetto, l’empatia, il mettersi in gioco e il piacere dell’incontro. Oltre ai performer (in media quattro attori) e al conduttore (che guida la performance in dialogo col pubblico), nel Playback vi è anche il ruolo del musicista, che ha il compito di commentare musicalmente (improvvisando con percussioni e/o vari strumenti musicali) i diversi momenti dell’azione scenica e di scandire il ritmo delle rappresentazioni, in piena sintonia e sinergia con gli attori.
Il pubblico degli studenti, ragazze e ragazzi, che partecipano agli eventi di Playback vengono coinvolti nella performance, attraverso metodologie attive, a volte in brevi lavori in sottogruppi, affinché possano condividere i contenuti incontrati prima, durante o dopo un percorso di teatro sociale su tematiche specifiche come la discriminazione di genere, o progetti legati a questioni sociali importanti.
Attori e musicista, quindi, restituiscono all’istante, in forma scenica e simbolica, quanto espresso dai ragazzi, favorendo dinamiche di rispecchiamento e
identificazione dell’uditorio. Attraverso il processo di narrazione e messa in scena, i giovani hanno così l’opportunità di raccontare le proprie esperienze personali. Questo li porta a riflettere sul proprio vissuto e a riconoscere parti della loro identità che spesso possono essere state oscurate da aspettative o stereotipi. La possibilità di vedere la propria storia “riflessa” sul palcoscenico, in un contesto di ascolto empatico, favorisce una presa di coscienza che va oltre la dimensione puramente didattica. Lo spettacolo di Playback si sviluppa quindi a partire da tematiche di rilievo socio-culturale (contrasto degli stereotipi di genere, dalla formazione/educazione alla realizzazione personale e professionale ecc.) con l’obiettivo di facilitare una più profonda comprensione delle declinazioni individuali e gruppali.

- Qual è secondo te la forza del linguaggio teatrale in ambito sociale?
Per me il teatro ha la responsabilità di avere una funzione sociale, ed il teatro sociale quando non si limita a comunicare informazioni, ma trasforma le emozioni in esperienza condivisa, favorisce il confronto e l’empowerment personale, stimola un cambiamento culturale che parte dall’individuo per arrivare alla comunità. La sua potenza è l’azione trasformativa. Nei percorsi educativi e formativi l’arte può occupare un posto centrale, offrendo differenti linguaggi e piani di espressione/relazione per ogni individuo, riuscendo a favorire la crescita di ciascuno e la consapevolezza sia delle proprie risorse che dei bisogni. Il Teatro Sociale, può far cambiare lo sguardo, trasformando il limite in potenzialità, la sofferenza in poesia, il teatro in rito festivo comunitario creando un’occasione di riconoscimento reciproco, in una società dove l'”Incontro” con l’altro trova molte difficoltà.
Il progetto della Compagnia Teatro di Mutuo Soccorso è un esempio di come l’arte possa essere messa al servizio di cause sociali, offrendo strumenti per affrontare tematiche difficili e promuovendo il dialogo su questioni che ci riguardano tutti. Una lezione di umanità e impegno che lascia il segno.
A cura di Francesca Fabbrini – Compagnia Filodirame